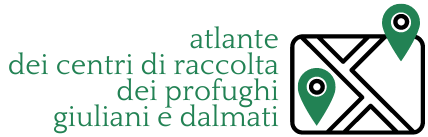Spostamenti forzati di popolazione in Europa post II GM – Trattato di Parigi – Memorandum di Londra – Trattato di Osimo – Esodo giuliano-dalmata – Opzioni –Motivazioni dell’esodo – Politica della fratellanza italo-slava – Città dell’esodo: Zara – Città dell’esodo: Fiume – Città dell’esodo: Pola – Vergarolla – Toscana – Direzioni dell’esodo – Posti di Ristoro – Centri Raccolta Profughi – Ufficio per le Zone di confine – Opera assistenza ai profughi giuliano e dalmati (Oapgd) – Accoglienza e assistenza – UNRRA – IRO – AAI
Spostamenti forzati di popolazione in Europa post II GM
Subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale l’Europa fu toccata dal fenomeno degli spostamenti forzati di popolazione, eredità diretta del conflitto e della contrastata definizione dei confini. Un ingente flusso di profughi attraversò così le strade del continente. Ad assumere, sul piano numerico, un peso specifico rilevante furono i Volksdeutschen, i cosiddetti tedeschi etnici di Polonia, Cecoslovacchia (l’area dei Sudeti) e di altri territori dell’Europa orientale (Ungheria e Romania). Assimilati ai nazisti sconfitti, essi vennero espulsi da territori dove risiedevano da generazioni o nei quali erano stati collocati dalla politica di espansionismo pantedesco intrapresa da Hitler. Si trattò, complessivamente, di circa 12 milioni di persone. I casi di maggior rilevanza riguardarono la Polonia (8 milioni) e la Cecoslovacchia (3 milioni).
Trattato di Parigi
Il 29 luglio 1946 si aprì a Parigi la Conferenza di Pace, conclusasi con la firma, il 10 febbraio 1947, del Trattato di Pace. La posizione della diplomazia italiana, rappresentata da Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio con la delega agli Affari esteri, era assai debole. L’Italia, che aveva dichiarato guerra, fu infatti considerata dalle potenze alleate come un paese sconfitto.
Il Trattato portò così all’assegnazione di Gorizia e Monfalcone all’Italia, unitamente alle estremità occidentali della Venezia-Giulia. La sorte di Trieste fu quella di essere internazionalizzata attraverso l’istituzione del Territorio Libero di Trieste (TLT) con una sua suddivisione in Zona A – che abbracciava un’area estesa da Duino a Muggia comprendente quindi anche Trieste – affidata a un Governo Militare Alleato (GMA) e in Zona B, comprendente la parte nord-occidentale dell’Istria, retta dall’amministrazione jugoslava, che si vide assegnare anche Pola, Fiume, Zara, le isole di Cherso, Lussino, Lagosta e Pelagosa.
Memorandum di Londra
Il 5 ottobre 1954 le diplomazie di Stati Uniti, Gran Bretagna, Jugoslavia e Italia siglarono il Memorandum di Londra che pose fine ai governi militari nella Zona A e nella Zona B, cedendo l’amministrazione della prima all’Italia ed estendendo nella seconda l’amministrazione civile jugoslava, che, con una modifica rispetto al confine precedente, vide assegnate a proprio vantaggio nuove porzioni territoriali tra le due aree dei centri istriani di Muggia e San Dorligo della Valle, rimasti invece sotto l’amministrazione italiana.
La fine dell’amministrazione militare alleata nella Zona A del TLT sanciva anche il ritorno di Trieste all’Italia. Sul piano formale, l’accordo non si presentava come un trattato diplomatico definitivo, ma manteneva un carattere di provvisorietà, poiché il protocollo faceva ufficialmente riferimento soltanto al trasferimento dell’amministrazione civile, concedendo così, almeno sulla carta, la possibilità dei due firmatari di rivendicare la sovranità sulla Zona A e sulla Zona B dell’oramai dissolto Territorio Libero di Trieste.
Trattato di Osimo
Il 10 novembre 1975 Italia e Jugoslavia firmarono il Trattato di Osimo. Ultimo atto del dopoguerra, il documento sancì il carattere definitivo del confine italo-jugoslavo: l’Italia rinunciava definitivamente alla sovranità sulla oramai ex Zona B del Territorio Libero di Trieste, mentre la Jugoslavia abbandonava ogni ambizione sulla Zona A. La linea di demarcazione tra la Zona A e la Zona B divenne quindi ufficialmente il confine tra i due paesi.
Esodo giuliano-dalmata
Tassello italiano del più ampio mosaico europeo degli spostamenti forzati di popolazione, l’esodo fu un processo lungo e di grande portata: iniziò nel 1944 e si concluse ufficialmente nel 1956, sebbene alcune partenze continuarono fino alla prima metà degli anni Sessanta. Sul piano numerico coinvolse circa 300.000 persone, 250.000 delle quali appartenenti alla popolazione italiana. A loro si accodò anche una rappresentanza di circa 34.000 sloveni e 12.000 croati, per la gran parte di origine istriana, non disposti ad accettare la nuova realtà statuale jugoslava.
Le partenze si snodarono seguendo tre ondate: la prima, iniziata nel 1944 e quindi a guerra ancora in corso riguardò Zara, distrutta dai bombardamenti Alleati, la seconda avvenne tra l’estate del 1945 e il 1951, interessando le città di Fiume, Pola e gli altri territori dell’Istria annessi alla Jugoslavia, mentre l’ultima si registrò tra il 1953 e il 1956, e coinvolse soprattutto la Zona B del Territorio Libero di Trieste.
L’esodo costituì quindi una frattura storica, che con la scomparsa pressoché totale del gruppo nazionale italiano da una delle sue aree di insediamento storico, spezzò una linea di continuità che durava dai secoli precedenti.
Opzioni
Tra il 1947 e il 1948, dopo la firma del Trattato di Parigi, si aprì la prima tornata di opzioni per i giuliano-dalmati che non volevano rimanere sotto la Jugoslavia. In tutta l’Istria ci furono situazioni molto diverse: alcuni paesi si svuotarono, in altri, invece, gli abitanti furono trattenuti. Il motivo ufficiale (che si trova nei fondi archivistici) per ogni opzione negata riguardava il criterio su cui si basava il diritto all’opzione, ovvero la lingua d’uso (e la presunta appartenenza nazionale ad essa collegata). le opzioni respinte erano giustificate sempre con la dicitura: di lingua e di nazionalità croata/slovena. Ciò avvenne anche per altri motivi: in primis perché a lasciare l’Istria erano delle professionalità indispensabili, in quel momento, alla ricostruzione della Jugoslavia socialista, poi perché lo svuotamento di cittadine e campagne avrebbe creato grave imbarazzo al regime jugoslavo. E infine alcuni furono trattenuti perché sospettati di cominformismo dopo la rottura tra Tito e Stalin del giugno 1948.
I trattenimenti avvennero anche a seguito di pesanti azioni di intimidazioni, pressioni, pestaggi, sequestro dei documenti. Ciò non impedì le fughe, avvenute però in condizioni di grave rischio.
Motivazioni dell’esodo
L’esodo fu una scelta multicausale alla base della quale si intrecciarono elementi di natura politica, economica, culturale e sociale.
Una delle spinte principali fu di natura politico-nazionale e va ricondotta alle trasformazioni introdotte dai poteri popolari jugoslavi nella società istriana, che resero molto complicato per le comunità italiane il mantenimento della propria identità nazionale. A ciò si aggiunsero poi altri elementi come la paura generalizzata, eredità della stagione delle foibe, le pressioni e le intimidazioni mirate contro quanti non si erano uniformati al nuovo regime jugoslavo, unitamente all’oppressione politica e, non per ultimo, alle precarie condizioni economiche.
Possiamo quindi parlare dell’esodo come di un processo espulsivo avvenuto non in seguito a provvedimenti legislativi emanati da parte del governo jugoslavo, ma come il risultato di pressioni ambientali portate avanti proprio dal potere jugoslavo che creò nella comunità italiana le condizioni necessarie a partire. Siamo dunque di fronte a una solida connessione tra l’azione dei poteri popolari, l’edificazione della società socialista e l’esodo.
Politica della fratellanza italo-slava
La posizione ufficiale del regime jugoslavo non era quella di eliminare la presenza italiana, ma di promuovere una politica di fratellanza italo-slava, che rivolgesse la sua attenzione soltanto agli antifascisti e ai comunisti di comprovata fede, da contrapporre a quelli che rientravano nella generica categoria dei nemici del popolo, poiché non disposti a sostenere la linea del Pcj, ad accettare la creazione del nuovo ordine socialista e l’annessione dell’Istria alla Jugoslavia. La fratellanza italo-slava mirava quindi a coniare un gruppo nazionale omologato, integrato con il nuovo sistema politico e conforme agli orientamenti del regime.
La maggioranza della popolazione italiana, quindi quella non rispondente ai canoni indicati dal regime, era invece destinata a rimanere fuori dai margini: non essendo possibile una sua omologazione, essa andava dunque epurata e contrastata attraverso misure legislative e mutamenti strutturali di carattere coercitivo, tali da provocarne – al di là delle dichiarazioni formali sui diritti delle minoranze – un impoverimento sul piano economico, politico, culturale e sociale che l’avrebbero indotta a partire.
Città dell’esodo: Zara
La città dalmata, prima tappa dell’esodo, rappresentò un’eccezione, poiché, contrariamente a quanto avvenuto nelle altre località dell’Istria, la spinta a partire non fu data dalla consapevolezza del carattere definitivo dell’amministrazione jugoslava, ma dalle 54 incursioni alleate che dal 2 novembre 1943 al 31 ottobre 1944 provocarono la morte di almeno 1.500 abitanti e la distruzione della quasi totalità delle abitazioni (stime vicine all’85%).
Di fronte al peso dei bombardamenti, la gran parte degli zaratini diede vita a uno sfollamento senza ritorno che, di fatto, si trasformò in esilio. Alcuni si diressero verso le campagne circostanti, altri decisero invece di spingersi a bordo del piroscafo Sansego verso Trieste, Venezia e le regioni affacciate sull’altra sponda dell’Adriatico. In città restò dunque una minima parte di italiani, molti dei quali scelsero la strada dell’abbandono già nell’autunno del 1944, e cioè subito dopo l’instaurazione del potere jugoslavo, il cui avvento trascinò con sé una lunga scia di abusi e violenze. Al termine del conflitto restarono in città poco meno di 10.000 abitanti sul totale dei 21.372 censiti nel 1940.
Città dell’esodo: Fiume
A Fiume la popolazione italiana, circa i tre quarti degli abitanti, maturò fin da subito la percezione di un’annessione pressoché scontata alla Jugoslavia. Una convinzione diffusasi in seguito all’atteggiamento tenuto dalle grandi potenze, che mai sembrarono mettere in dubbio l’inserimento della città nel quadro politico e istituzionale della nuova Jugoslavia socialista. A partire dalla fine dell’estate del 1945 iniziò quindi l’esodo degli italiani che assume proporzioni consistenti già nel corso dell’anno successivo. Tra il marzo 1946 e il settembre 1947 abbandonarono la città circa 20.000 persone alle quali se ne aggiunsero altre 9.300 alla fine del 1948. Complessivamente le partenze da Fiume ammontarono a circa 36.000 unità, su un totale di circa 52.000 abitanti.
Città dell’esodo: Pola
Governata provvisoriamente dagli americani Pola costituì una tappa cruciale della prima fase dell’esodo. Appena conosciute le decisioni della Conferenza di pace, nel luglio 1946 il Cln cittadino diede vita al Comitato per l’esodo da Pola, il cui primo atto fu, come tentativo di pressione, la raccolta di dichiarazioni di esodo della popolazione nel caso la città venisse assegnata alla Jugoslavia.
I risultati furono piuttosto chiari: erano 28.058 su un totale di 31.700 gli abitanti disposti a prendere la via dell’esilio, evidenziando così il carattere plebiscitario dell’esodo che coinvolse trasversalmente l’intera società cittadina.
Il 15 ottobre 1946 si chiuse la conferenza di Pace di Parigi che stabilì la cessione della città alla Jugoslavia. Il 24 dicembre 1946 il Comitato per l’esodo dichiarò così aperto l’esodo, che da un punto di vista cronologico si registrò tra il dicembre del 1946 e il marzo 1947, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Parigi e del passaggio della città alla Jugoslavia, previsto per il 15 settembre 1947. Un esodo preventivo, legato al timore di quanto potesse accadere in città dopo l’instaurazione del potere jugoslavo, già sperimentato direttamente dai polesani per alcune settimane nella primavera del 1945. La città si svuotò così in massa e vide partire 28.000 dei suoi 32.000 abitanti.
Vergarolla
Il 18 agosto 1946 a Vergarolla si svolse una manifestazione sportiva alla quale assistettero numerose famiglie. Sulla spiaggia erano accatastate dalla fine del conflitto una ventina di mine, prive di innesco e periodicamente controllate dagli artificieri del GMA che le avevano più volte dichiarate sicure. Alle 14.15 le mine esplosero. Fu una strage: 65 morti e numerosi feriti.
Si trattò certamente di un’esplosione dolosa, ma l’assenza di rivendicazioni e la superficialità delle indagini promosse dalle autorità Alleate non furono in grado, così come quelle avviate nei periodi successivi, di determinare responsabilità e identificare esecutori e mandanti. Resta vivo il campo delle ipotesi, destinate a rimanere tali per l’assenza di prove concrete. Appare invece certa l’interpretazione dei polesani, per la gran parte dei quali Vergarolla rappresentò uno spartiacque, poiché da quel momento in poi anche quanti avevano mostrato più di un’incertezza sulla prospettiva dell’esodo, decisero di rompere gli indugi, convincendosi che la partenza sarebbe stata l’unica soluzione.
Toscana
Il Saarbrücken, questa la denominazione originaria del piroscafo, fu costruito a Brema tra il 1922 e il 1923 per la Norddeutscher Lloyd, compagnia di navigazione tedesca che la utilizzò come transatlantico per passeggeri lungo le rotte del Nord Europa e dell’Asia occidentale.
Nel 1935 il governo italiano promosse l’acquisto di navi da compagnie straniere, in modo tale da poter contare, in previsione dell’imminente Guerra di Etiopia, su un numero sufficiente di imbarcazioni per garantire il trasporto delle truppe in territorio africano. Tra queste vi era anche il Saarbrücken, ribattezzato Toscana.
Dopo l’Etiopia, fu la volta della Spagna, poiché il Toscana fu adibito al trasporto dei soldati inviati dall’Italia fascista a combattere nella Guerra civile spagnola.
Durante la Seconda guerra mondiale si trasformò in nave ospedale adibita, tra il 1941 e il 1945, al trasporto di ammalati e feriti.
Nel 1946 fu impiegata per il rimpatrio di profughi ed ex prigionieri di guerra dalla Libia e della Tunisia, mentre l’anno seguente fu utilizzata dal governo italiano per evacuare i profughi di Pola decisi a lasciare la città. Tra il 3 febbraio e il 20 marzo compì dieci viaggi, sette con scalo al porto di Venezia e tre al porto di Ancona, trasportando circa 16.800 persone. Nel 1948, dopo opportuni lavori di ammodernamento eseguiti dal Cantiere San Marco a Trieste, il piroscafo riprese la navigazione per il trasporto degli emigranti da Trieste verso l’Australia. Intraprese l’ultimo viaggio nel 1960, prima di essere disarmato e demolito nel 1961.
Direzioni dell’esodo
Una parte dei giuliani dalmati costituirà un serbatoio per l’emigrazione transoceanica verso l’Australia, gli Stati Uniti, il Canada e il Sudamerica, entrando, in parte, nei programmi di emigrazione assistita varati dall’International Refugee Organization (Iro), organizzazione delle Nazioni Unite che aveva come obiettivo il ricollocamento di rifugiati, Displaced Person’s e profughi, compresi i giuliano-dalmati.
La quasi totalità degli esuli scelse però l’Italia come meta finale della propria traiettoria, distribuendosi su tutto il territorio nazionale. Un censimento del 1958 evidenziava come l’82% dei profughi fosse dislocato nelle regioni dell’Italia settentrionale, il 10% in quella centrale e il restante 8% nelle regioni del Sud, in Sicilia e in Sardegna.
Posti di Ristoro
Nelle stazioni ferroviarie e nei porti di molte città italiane furono predisposti posti di ristoro per fornire assistenza ai profughi giuliano-dalmati di passaggio. A predisporre tali strutture furono soprattutto le istituzioni locali grazie all’opera degli Enti comunali di assistenza (Eca), coadiuvati attivamente dalla Croce rossa italiana (Cri) e dalle sezioni locali della Pontificia commissione di assistenza (Pca).
Centri di Raccolta Profughi
Giunti in Italia gli esuli giuliano-dalmati trovarono ricovero all’interno di Centri di Raccolta Profughi, diffusi su tutto il territorio nazionale e ricavati da complessi in disuso. Inizialmente affidati al ministero dell’Assistenza post-bellica, divennero, dopo la chiusura di tale ministero, di competenza del ministero dell’Interno che ne assunse la gestione attraverso le varie prefetture. Il numero delle strutture andò incontro a una progressiva riduzione: dalle 109 del 1947 esse passarono alle 41 del 1952, fino ad arrivare alle 31 del 1954 e alle 15 del 1963.
Ufficio per le Zone di confine
Di fronte al peso sempre più rilevante raggiunto dalle partenze, il governo italiano creò un organismo in grado di assumere il ruolo di interprete delle iniziative politiche e assistenziali portate avanti dall’esecutivo nei confronti dei giuliano-dalmati.
Il 6 gennaio 1946 nasceva così l’Ufficio per la Venezia-Giulia (UVG) che, posto sotto le dipendenze del ministero dell’Interno, concentrò la sua azione in una duplice direzione: da un lato sovvenzionamento e coordinamento delle iniziative di carattere assistenziale in favore dei profughi, dall’altro sostegno, soprattutto sul piano economico, ai vari comitati giuliani, promuovendone la nascita nelle località maggiormente toccate dall’afflusso di esuli.
Dopo tre mesi dalla fondazione, Alcide De Gasperi decise di trasferire le competenze dell’UVG in seno alla Presidenza del Consiglio, per evitare conflitti di competenze tra la stessa Presidenza e il ministero dell’Interno.
Fu così lo stesso De Gasperi, con decreto del 1° novembre 1947 a decidere l’accentramento di tutte le competenze dell’UVG sotto un unico ente, denominato Ufficio per le zone di confine (Uzc).
La responsabilità politica del nuovo organismo fu affidata a Giulio Andreotti, mentre alla guida dell’Ufficio venne nominato Silvio Innocenti, che aveva maturato durante il fascismo importanti esperienze prefettizie.
L’Uzc non limitò le sue competenze alla sola attività assistenziale, ma svolse un fondamentale ruolo di coordinamento tra il centro e le amministrazioni locali nella delicata fase dell’assistenza, dello smistamento e della sistemazione dei profughi. Contemporaneamente, l’ente si occupò anche di coordinare l’azione generale del governo nelle aree di confine, assumendo la funzione di canale di trasmissione e collegamento tra Roma e il territorio istriano, avvalendosi in tal senso delle informazioni raccolte dalla rete di collaboratori che, successivamente trasmesse all’Uzc, avrebbero permesso alle autorità governative di elaborare le strategie di intervento sul piano politico e dei flussi di finanziamento. L’Uzc rimase in attività fino al 1954.
Opera assistenza ai profughi giuliano e dalmati (Oapgd)
Nel febbraio 1947 sorse a Roma il Comitato nazionale per i rifugiati italiani (Cnri) che poteva vantare nel proprio organigramma personalità di spicco della scena politica del paese come Alcide De Gasperi, nominato presidente onorario, e gli ex presidenti del consiglio Francesco Saverio Nitti, Vittorio Emanuele Orlando, Ferruccio Parri e Ivanoe Bonomi, componenti del comitato d’onore.
L’organismo, nel 1949, si trasformò in ente morale e mutò denominazione in Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati (Oapgd). Presieduto da Oscar Sinigaglia, industriale siderurgico e presidente della Finsider, l’ente, che si avvaleva di una struttura composta da comitati provinciali direttamente dipendenti da quello centrale, indirizzò i propri sforzi lungo tre direttrici principali: casa, lavoro e assistenza. Si occupò anche della costruzione di collegi, preventori e colonie marine e montane che, realizzate grazie al contributo decisivo dei ministeri degli Interni e della Pubblica istruzione, ospitavano bambini di età compresa tra i sei e i dodici anni.
Nel quadro delle iniziative in favore di bambini e ragazzi portate avanti dall’Opera, che nel 1978 concluse la sua intensa attività, occorre infine menzionare anche la Giornata del Bambino Profugo, celebrata annualmente in tutta Italia con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’assistenza dei piccoli giuliani.
Accoglienza e assistenza
Fin dalle prime fasi dell’esodo, il governo italiano iniziò a intraprendere in favore dei profughi misure assistenziali di primo intervento seguite, nei periodi successivi, da provvedimenti legislativi e normativi più organici volti a potenziare e superare quelli precedenti che dovettero, inevitabilmente, rapportarsi con la situazione generale di un paese ancora profondamente segnato dalle ferite della guerra.
Oltre all’aspetto prettamente assistenziale, l’azione governativa, nella quale assunse un ruolo di primo piano l’Ufficio per le Zone di Confine, mirò anche a intervenire nell’ambito del collocamento lavorativo e della sistemazione abitativa. In tal senso un punto di svolta si ebbe nel 1952 con l’approvazione della legge n.137, meglio nota come legge Scelba, che sancì l’obbligo da parte delle aziende e delle imprese appaltatrici di opere pubbliche di assumere al loro interno la quota del 5% di profughi e assegnò a questi ultimi il 15% dei quartieri di nuova edilizia popolare, portando così alla creazione, in oltre quaranta città italiane, dei cosiddetti borghi giuliani.
Si trattò di un passaggio fondamentale che permise ai giuliano-dalmati di abbandonare progressivamente la precarietà dei campi per trasferirsi in abitazioni vere e proprie, facilitando così il loro inserimento nelle realtà che li avevano accolti, nelle quali, accanto a manifestazioni di viva e concreta solidarietà, emersero anche i contorni di un’accoglienza segnata da esclusione, emarginazione e pregiudizio. Altri importanti passaggi legislativi in favore dei profughi furono emanati nel 1956, 1958 e 1961.
UNRRA
Nel 1943, tramite una convenzione liberamente stipulata da 44 paesi membri delle Nazioni Unite o ad esse associati in guerra, venne istituita l’United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), con lo scopo di fornire assistenza e supporto alla ricostruzione per le popolazioni delle aree liberate dalle forze armate delle Nazioni Unite o abbandonate dal nemico in ritirata. Gli aiuti forniti includevano cibo e vestiario, misure per il rimpatrio dei prigionieri e dei profughi, supporto alla ripresa delle produzioni agricole e industriali, e al ripristino dei servizi essenziali.
L’UNRRA iniziò la sua attività in Italia nel luglio del 1944, affrontando sin da subito la problematica delle Displaced Persons (DPs), individui sfollati e senza casa a causa del conflitto. Sebbene ciò non fosse contemplato nel suo mandato originale, l’UNRRA istituì campi di transito e accoglienza per assistere queste persone.
Nonostante gli sforzi profusi, l’UNRRA incontrò notevoli difficoltà, inclusa la gestione di un numero crescente di DPs, in particolar modo ebrei, che rifiutavano il rimpatrio a causa dei cambiamenti geopolitici intervenuti nel dopoguerra.
L’UNRRA tentò di facilitare il rimpatrio attraverso un processo che prevedeva la preparazione nei campi, assistenza burocratica e logistica per il viaggio, e la collaborazione con governi e consolati per il ricollocamento delle DPs in paesi disposti ad accoglierle. Tuttavia, molti preferirono emigrare verso altri paesi al di fuori dell’Europa in particolare gli ebrei sopravvissuti alla Shoah si diressero verso la Palestina.
Le attività dell’UNRRA terminarono quando il mandato per la gestione delle DPs fu trasferito all’IRO (Organizzazione Internazionale per i Rifugiati) nel 1947, inaugurando una nuova fase nell’assistenza post-Seconda Guerra Mondiale agli sfollati.
IRO
L’Organizzazione Internazionale per i Rifugiati (IRO), nata il 12 dicembre 1946 come successore dell’UNRRA, fu creata per affrontare la crisi dei rifugiati e degli sfollati post-Seconda Guerra Mondiale, che ammontavano a decine di milioni in Europa. La sua missione era indirizzata principalmente al rimpatrio e al reinsediamento degli sfollati, soprattutto quelli provenienti dal blocco comunista.
L’IRO operò con un mandato chiaro di assistere i veri rifugiati e sfollati sia nei centri di raccolta profughi che fuori, promuovendo il loro rientro nei paesi d’origine o facilitando il loro reinsediamento in nuovi paesi di accoglienza. Il suo atto costitutivo enfatizzava la necessità di un’azione internazionale per risolvere il problema dei rifugiati, riconoscendo le obiezioni al rimpatrio e privilegiando l’emigrazione come opzione accettabile.
Nonostante le sfide, soprattutto nel convincere i paesi ad aumentare le quote di immigrazione, l’IRO ottenne risultati positivi. Tuttavia, le restrizioni imposte da alcuni paesi, come gli Stati Uniti con il Displaced Persons Act, limitarono l’ampiezza dell’emigrazione. Altri paesi, basandosi su necessità di manodopera, adottarono approcci più flessibili.
L’IRO cessò le sue operazioni nel 1951, passando le sue funzioni al Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (CIME) e, in seguito, all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) nel 1989. Inoltre, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) prese il testimone per la protezione internazionale dei rifugiati.
Alla chiusura dell’IRO, in Italia rimasero circa 9.000 rifugiati nei centri e 10.000 fuori, con il governo italiano che si assunse l’assistenza in collaborazione con l’ACNUR e altre agenzie volontarie.
AAI
L’Amministrazione per gli Aiuti Internazionali (AAI), operante dal 1945 al 1977, rappresenta un capitolo significativo nella storia dell’assistenza internazionale post-bellica in Italia. Guidata da Lodovico Montini, l’AAI fu cruciale nel processo di ricostruzione sociale del paese e nell’implementazione dei programmi di aiuti internazionali.
Con la cessazione dei rifornimenti gratuiti dell’UNRRA a giugno 1947, gli Stati Uniti presero le redini della ricostruzione, affidando il nuovo programma di assistenza all’AAI. Questa si sostituì alla Delegazione del governo italiano per i rapporti con l’UNRRA, inserendosi in un contesto di politiche nazionali e dinamiche internazionali.
L’AAI, divenuta nel 1954 “Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali”, si impegnò nell’assistenza ai nuovi rifugiati, in linea con la Convenzione di Ginevra del 1951. Le sue iniziative spaziavano dall’assistenza alimentare e distribuzione di prodotti tessili alla popolazione bisognosa, all’addestramento professionale, supporto a scuole materne e organizzazione di soggiorni vacanza. L’AAI gestiva anche i campi residenziali per profughi e forniva assistenza medica e sostegno per l’emigrazione.
Tra le sue attività spiccavano anche i programmi edilizi del Comitato UNRRA-Casas, che includevano la costruzione di alloggi popolari per le famiglie bisognose e per i profughi, dimostrando un impegno concreto nella ricostruzione materiale e sociale del paese.
L’AAI fu soppressa nel 1977, segnando la fine di un’epoca significativa nell’assistenza internazionale e nel supporto alla ricostruzione post-Seconda guerra mondiale in Italia.