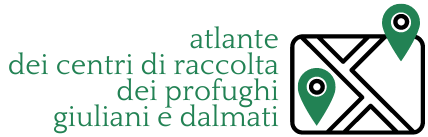Cronologia
30 ottobre: Plebiscito del Consiglio Nazionale Italiano di Fiume per l’annessione all’Italia
3 novembre: firma a Villa Giusti (Padova) dell’armistizio tra Italia e Austria-Ungheria. Le truppe italiane sbarcano a Trieste e il generale Carlo Pettiti di Loreto è nominato governatore della Venezia-Giulia. La Dalmazia è invece posta sotto un governatorato militare, con sede a Spalato, affidato all’ammiraglio Enrico Millo, che si trasformerà in struttura di carattere civile soltanto nel 1920.
1°dicembre: l’unione di Serbia e Montenegro con i territori appartenuti all’ex Impero austriaco (Bosnia, Slovenia, Croazia), porta alla nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (SHS), la cui reggenza è affidata al principe Aleksandar Karađorđević.
28 giugno: firma del Trattato di Pace di Versailles, che non concede all’Italia i territori previsti dal Patto di Londra. Prende così forma il concetto di vittoria mutilata coniato da Gabriele D’Annunzio.
11-12 settembre: Gabriele d’Annunzio alla guida dei legionari occupa Fiume dando inizio alla cosiddetta Impresa di Fiume.
13 luglio: incendio a Trieste del Narodni Dom, centro culturale delle organizzazioni slovene, a opera delle squadre guidate da Francesco Giunta, squadrista toscano chiamato da Mussolini alla guida del fascismo triestino. È il primo atto del fascismo di confine. L’episodio segue i cosiddetti fatti di Spalato. Nonostante la città dalmata fosse esclusa dai territori che il Patto di Londra avrebbe dovuto affidare all’Italia, il governo di Roma aveva deciso di far stazionare nel porto l’incrociatore Puglia, con la speranza di rafforzare le posizioni italiane ai negoziati di Parigi. L’11 luglio si verificano incidenti tra nazionalisti croati e militari italiani, due dei quali morirono.
14 luglio: incendio del Narodni Dom di Pola in Istria a opera delle squadre fasciste.
20 agosto: Gabriele d’Annunzio proclama a Fiume la Reggenza del Carnaro.
12 novembre: il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi, Croati, Sloveni firmano il Trattato di Rapallo con il quale l’Istria, Zara e le isole di Cherso, Lussino, Pelagosa e Lagosta diventano definitivamente parte del Regno d’Italia. Fiume, per la quale è prevista la costituzione di uno stato indipendente, viene dichiarata città libera.
24-29 dicembre: D’Annunzio non accetta la firma del Trattato di Rapallo e lo status di Fiume, rifiutandosi di abbandonare la città. Il governo italiano invia reparti dell’esercito che si scontrano con i volontari dannunziani (Natale di sangue). Termina così l’esperienza della Reggenza del Carnaro.
27 ottobre: marcia su Roma
28 ottobre: il re Vittorio Emanuele III incarica Mussolini di formare un nuovo governo. Inizia l’ascesa al potere del partito fascista. Nella Venezia-Giulia si delinea in modo sempre più netto il fascismo di confine che porta avanti una politica di omologazione nazionale e italianizzazione forzata della popolazione slovena e croata.
17 settembre: accordo italo-jugoslavo di Roma e conseguente annessione di Fiume all’Italia.
14 novembre: in una circolare riservata inviata ai prefetti della Venezia-Giulia, il Ministero dell’Interno illustra le coordinate del «progetto di italianizzazione dei territori occupati da gruppi di allogeni». Tra il 1925 e il 1930 sono adottate una serie di misure che vanno dalla proibizione di utilizzare la lingua slovena e croata negli uffici amministrativi, nei tribunali e nello spazio pubblico, allo scioglimento delle associazioni culturali, politiche e sportive, fino ad arrivare alla soppressione delle testate quotidiane. A seguito di tali misure circa 105.000 tra sloveni e croati decidono di lasciare la Venezia-Giulia e trasferirsi nel vicino Regno dei Serbi, Croati, Sloveni.
6 settembre: il Tribunale speciale per la sicurezza dello stato condanna a morte quattro cittadini sloveni accusati di aver organizzato alcuni attentati contro le sedi istituzionali e quelle del partito fascista a Trieste, nonché di cospirazione per l’abbattimento del regime. La sentenza è eseguita al poligono militare di Basovizza.
10 giugno: dichiarando guerra a Gran Bretagna e Francia, l’Italia fascista entra al fianco della Germania hitleriana nel secondo conflitto mondiale.
6 aprile: Hitler decide di invadere, insieme all’Italia e all’Ungheria, il territorio jugoslavo che viene occupato in pochi giorni.
16 aprile: proclamazione dello stato indipendente croato (NDH), alla cui guida è posto Ante Pavelić.
27 aprile: costituzione del Fronte di Liberazione sloveno.
15 maggio: costituzione delle province di Zara, Cattaro e Spalato.
2 – 15 dicembre: il 2 dicembre si apre il secondo processo di Trieste a carico di una sessantina di imputati accusati di cospirazione, terrorismo e spionaggio. Tra loro vi sono anche alcuni membri del Tigr. Il procedimento, affidato anche in questo caso al Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato, si conclude con pene durissime: sono comminati oltre 960 anni di carcere e cinque condanne a morte, eseguite a mezzo fucilazione il 15 dicembre.
18 luglio: rappresaglia dell’esercito italiano a seguito di azioni partigiane nel villaggio di Podhum nei pressi di Fiume. L’ordine è impartito dal prefetto di Fiume Temistocle Testa.
31 luglio: istituzione dell’Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia-Giulia, creato dal regime fascista per contrastare l’azione del movimento partigiano sloveno.
13-14 giugno: il Consiglio della liberazione della Croazia proclama la lotta per la liberazione e l’unificazione di tutte le località croate, comprese Istria, Fiume, Zara e le isole dalmate.
8 settembre: entrata in vigore dell’armistizio sottoscritto a Cassibile, il 3 settembre, tra l’Italia e gli Alleati.
9-12 settembre: occupazione della Venezia-Giulia da parte delle truppe tedesche che concentrano i propri sforzi sui punti nevralgici di Pola, Fiume e Trieste, trascurando la fascia di territorio interno occupata dalle forze partigiane croate e slovene.
9-13 settembre: insurrezione in Istria guidata dal movimento popolare di liberazione sloveno e croato.
11-12 settembre: forze tedesche occupano Pola, mentre le forze partigiane occupano Pisino.
13 settembre: il Fronte di liberazione croato per l’Istria, organismo dipendente dal Consiglio territoriale antifascista di liberazione popolare della Croazia (Zavnoh) esprime a Pisino la volontà di annettere alla Croazia l’Istria, Fiume, Zara e le isole dell’Adriatico (Dichiarazione di Pisino).
16 settembre: il Consiglio di liberazione nazionale della Slovenia proclama l’annessione alla Slovenia del litorale della Venezia-Giulia.
settembre: durante l’insurrezione e a seguito del vuoto di potere verificatosi dopo la firma dell’armistizio, si verificano in tutta l’Istria i primi infoibamenti. Scompaiono, complessivamente, tra le 500 e le 700 persone.
1-12 ottobre: costituzione della Zona di operazioni litorale adriatico (Adriatisches Kunstenland) comprendente le province di Pola, Fiume, Trieste, Udine, Gorizia e Lubiana. Hitler nomina commissario supremo della zona Friedrich Rainer, già governatore della Carinzia. L’area sarà separata dalla Repubblica sociale italiana e sottoposta alla diretta amministrazione militare tedesca. Inizia l’offensiva tedesca sull’Istria che si concluderà, il 12 ottobre, con l’occupazione della penisola.
29-30 novembre: si riunisce a Jaice il Consiglio antifascista di liberazione nazionale della Jugoslavia che nomina Tito ed Edvard Kardelij, rispettivamente, presidente e vicepresidente del governo provvisorio. Nel corso della seduta lo stesso Consiglio sancisce la legittimità dei decreti di annessione pronunciati nel settembre 1943 dai Comitati di liberazione sloveno e croato.
2 novembre: Zara è colpita dal primo dei cinquantaquattro bombardamenti alleati che si susseguono fino al 31 ottobre 1944. In questo periodo la città è abbandonata dalla gran parte dei suoi abitanti. Inizia l’esodo.
6 gennaio: primo bombardamento aereo anglo-americano su Fiume
9 gennaio: primo bombardamento aereo su Pola. Ne seguiranno altri fino al 1945.
11 gennaio: con apposita ordinanza il prefetto di Trieste Cesare Pagnini istituisce la Guardia civica.
15 settembre: il Partito comunista italiano incoraggia il passaggio delle unità partigiane friulane e giuliane nel IX Korpus dell’esercito jugoslavo, ordinando nel contempo ai comunisti italiani di appoggiare le iniziative del Fronte di liberazione sloveno.
31 ottobre: l’esercito jugoslavo di liberazione entra a Zara.
7 febbraio 1945: alle malghe di Porzûs, in Friuli, sono uccisi diciassette partigiani della Brigata Osoppo, formazione di orientamento cattolico e laico-socialista, da parte di un gruppo di gappisti garibaldini filo-jugoslavi. L’episodio è meglio noto come eccidio di Porzûs.
30 aprile: insurrezione di Trieste.
1° maggio: entrano a Trieste i reparti della IV armata dell’esercito jugoslavo. Il Cln cittadino ordina il rientro dei propri reparti per evitare incidenti con l’esercito titino che occupa la città per quaranta giorni.
1° maggio: entrano a Pola le truppe dell’esercito di liberazione jugoslavo. Dopo quarantatré giorni lasciano la città, affidata dagli accordi di Belgrado a un Governo militare alleato.
3 maggio: l’armata jugoslava entra a Fiume, proclamando l’annessione della città alla Jugoslavia. La notte tra il 3 e il 4 maggio sono eliminate note personalità cittadine, sia fasciste che antifasciste. Inizia l’instaurazione del potere popolare.
9 maggio: si riunisce a Pola clandestinamente il Comitato cittadino polese, da cui nascerà il Cln di Pola organo rappresentativo delle forze antifasciste filo-italiane della città.
maggio: si verifica la seconda stagione di infoibamenti che oltre all’Istria e a Fiume colpisce soprattutto le province di Trieste e Gorizia, dove si registra il numero di vittime più elevato. Muoiono tra le 3.000 e le 4.000 persone.
15 maggio: fine della guerra in Jugoslavia.
9 giugno: accordo di Belgrado tra Jugoslavia e Alleati che prevede la divisione della Venezia-Giulia in due zone, la Zona A e la Zona, B rispettivamente affidate a un’amministrazione militare alleata e jugoslava.
12 giugno: ingresso a Pola delle truppe alleate e costituzione del Gma che assume i pieni poteri politici e civili della città.
11 settembre: riunitisi a Londra, i ministri degli Esteri dei paesi vincitori decidono di inviare nella Venezia-Giulia una Commissione interalleata per la definizione dei confini.
18 ottobre: introduzione nella Zona B viene introdotta la jugolira, nuova unità monetaria, creando un distacco con i territori della Zona A.
30 ottobre: sciopero a Capodistria contro l’introduzione della jugolira. Seguono disordini che portano alla morte di due persone.
7 marzo: la Commissione interalleata inizia la propria visita in Istria, al termine della quale sono elaborate quattro relazioni che propongono altrettante linee di demarcazione.
21-22 marzo: la Commissione interalleata giunge a Pola, accolta da una grande manifestazione organizzata dalla popolazione italiana della città.
3 luglio: si riunisce a Pola il Comitato per l’esodo istituito dal Cln cittadino.
6 luglio: manifestazioni di protesta della popolazione di Pola contro la decisione delle grandi potenze di accettare la linea francese che prevede il passaggio alla Jugoslavia della città e di gran parte della Venezia-Giulia.
7 luglio: a Pola inizia la raccolta delle dichiarazioni di esodo in caso di passaggio della città alla Jugoslavia. L’intento del Cln, promotore dell’iniziativa, è di presentare la documentazione alla Conferenza di pace. I risultati sono pubblicati sul quotidiano cittadino «L’Arena di Pola»: sono circa 28.000 i polesani che presentano domanda di esodo su un totale di poco meno di 32.000 abitanti.
29 luglio: si apre a Parigi la Conferenza di pace.
18 agosto: durante una manifestazione sportiva sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, esplodono in circostanze sospette delle mine, residuati bellici, provocando la morte di 65 persone.
22 settembre: il Cln di Fiume attraverso un appello invita gli italiani all’esodo. A gennaio 1946 sono già 20.000 i fiumani che hanno lasciato la città.
16 ottobre: a Parigi si chiude la Conferenza di pace che decreta l’approvazione della linea francese sancendo il passaggio di Pola e dell’Istria centro meridionale alla Jugoslavia.
23 dicembre: il Cln di Pola dichiara aperto l’esodo della popolazione italiana dalla città.
27 gennaio: inizia ufficialmente l’esodo da Pola sulla base di disposizioni e di un piano assistenziale concordato, su iniziativa del Cln cittadino, dal governo italiano in collaborazione con il Gma.
3 febbraio: primo viaggio del piroscafo Toscana, salpato da Pola alla volta del porto di Venezia. Complessivamente la nave, messa a disposizione dal governo italiano, compirà dieci viaggi: sette con scalo a Venezia e tre ad Ancona.
10 febbraio: l’Italia firma a Parigi il Trattato di Pace con le potenze vincitrici. Lo stesso giorno Maria Pasquinelli, insegnante toscana molto vicina agli ambienti fascisti e alla X Mas, uccide a Pola in segno di protesta il generale inglese Robert De Winton.
15 settembre: entrata in vigore del Trattato di Pace. Pola passa formalmente sotto la sovranità della Jugoslavia, che si vede assegnare circa tre quarti dell’intero territorio della regione. Viene delimitato il Territorio Libero di Trieste. Nella Zona B il generale Mirko Lovac assume il comando dell’Amministrazione militare jugoslava, mentre gli affari civili diventano di competenza del Comitato popolare distrettuale dell’Istria.
20 febbraio: creazione da parte dei Comitati regionali del litorale sloveno e dell’Istria croata del Circondario dell’Istria diviso nei distretti di Buie e Capodistria, città scelta come capoluogo.
20 marzo: Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia emanano la Nota Tripartita, con la quale prospettano il ritorno del Territorio Libero di Trieste all’Italia.
28 giugno: risoluzione del Cominform ed espulsione la Jugoslavia dall’organismo internazionale che riunisce i partiti comunisti europei. Da questo momento in poi il movimento comunista locale si divide tra cominformisti e titoisti.
19 settembre: scadenza dei termini per l’esercizio del diritto di opzione da parte della popolazione residente nei territori ceduti alla Jugoslavia. Saranno introdotte successivamente due proroghe al 16 maggio 1949 e al 23 marzo 1953.
16 aprile: elezioni amministrative jugoslave nella Zona B del Territorio Libero di Trieste per eleggere i membri dei comitati popolari di Capodistria e Buie. La popolazione italiana è vittima di pressioni e violenze da parte dei poteri popolari.
8 ottobre: Stati Uniti e Gran Bretagna emanano la Nota Bipartita con la quale annunciano l’intenzione di voler ritirare le proprie truppe dalla Zona A del Territorio Libero di Trieste e di volerne affidare l’amministrazione al governo italiano. La notizia provoca una grave crisi diplomatica tra Italia e Jugoslavia che schierano i propri eserciti lungo la frontiera arrivando molto vicine a un conflitto armato. La popolazione italiana della Zona B è vittima di nuove ondate di violenza, pressioni e intimidazioni.
5 ottobre: firma tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia e Jugoslavia del Memorandum di Londra che pone fine al governo militare nelle due zone del Territorio Libero di Trieste e modifica la linea di demarcazione a favore della Jugoslavia che si vede assegnare parte del territorio della ex Zona A nel territorio di Muggia. Il grande esodo dalla Zona B, già iniziato nei mesi precedenti, assume dimensioni sempre più consistenti. Il trattato prevede uno Statuto speciale per la minoranza italiana in Jugoslavia e quella slovena in Italia che garantisce loro il rispetto del carattere etnico del territorio e il diritto a poter coltivare rapporti e relazioni con le rispettive nazioni madri. Il Memorandum di Londra sancisce anche il ritorno di Trieste all’Italia.
26 ottobre: passaggio, a seguito della firma del trattato londinese, della Zona A del Territorio Libero di Trieste e della Zona B, rispettivamente a Italia e Jugoslavia.
5 gennaio: scadenza dei termini per le opzioni a seguito della firma del memorandum di Londra.
Estate: l’esodo della popolazione italiana può dirsi terminato. La Zona B perde dalla fine della guerra circa i due terzi della componente italiana residente sul territorio.
10 novembre: Italia e Jugoslavia firmano il Trattato di Osimo che pone fine alla controversia sui confini riconoscendo l’appartenenza della ex Zona A del Territorio Libero di Trieste all’Italia e della ex Zona B alla Jugoslavia.
30 marzo: con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 il Parlamento italiano istituisce il Giorno del Ricordo da celebrare il 10 febbraio per conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la Seconda guerra mondiale e nell’immediato Secondo dopoguerra (1943-1945), e della più complessa vicenda del confine orientale».