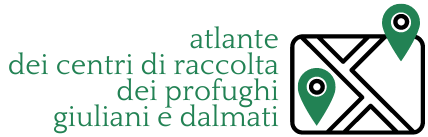Il progetto di ricerca sui centri di raccolta dei profughi giuliani e dalmati è promosso da Istituto Nazionale Ferruccio Parri e Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Scienze umane e sociali, patrimonio culturale (CNR-DSU), in collaborazione con la rete degli istituti associati alla Rete Parri, la Società di studi fiumani – Archivio Museo storico di Fiume (Roma).
Il coordinamento scientifico è affidato a Maurizio Gentilini (CNR) e Paolo Pezzino (Istituto nazionale Ferruccio Parri).
La ricerca è stata svolta da Costantino di Sante (Università degli studi del Molise) ed Enrico Miletto (Università degli Studi di Torino).
Oggetto della ricerca
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, scatenata dalla Germania nazista e dall’Italia fascista, l’intera Europa fu interessata dal flusso, spesso obbligato, di milioni di persone, che a causa degli eventi bellici e delle assegnazioni dei territori a seguito di nuovi protocolli furono costrette a lasciare i luoghi dove avevano vissuto per anni.
Il processo interessò direttamente anche l’Italia, che dovette firmare Trattati di pace che imponevano la perdita di territori, comprese le zone dell’Adriatico orientale: infatti con il Trattato di Parigi (1947) e il Memorandum di Londra (1954) l’Istria, Fiume e Dalmazia passarono sotto l’amministrazione della Jugoslavia. Di conseguenza la quasi totalità della popolazione italiana appartenente a queste regioni decise di abbandonarle, anche per sfuggire al regime comunista realizzato da Tito.
Tale processo, meglio noto come esodo giuliano-dalmata, coinvolse, oltre alla Venezia Giulia, anche Fiume e la Dalmazia, e rappresentò dunque il tassello italiano del più ampio mosaico degli spostamenti forzati di popolazione dell’Europa postbellica.
Arrivati nel nostro Paese come profughi, i giuliano-dalmati, nelle cui maglie si inserivano anche i molti fiumani che avevano abbandonato la propria città, furono sventagliati in una rete di campi e centri di raccolta dislocati sull’intero territorio nazionale.
Il progetto Atlante dei centri di raccolta dei profughi giuliani e dalmati si propone quindi di individuare, mappare e censire queste strutture, con esclusivo riferimento a quelle gestite dal Ministero dell’Interno.
Campi ma non solo, poiché l’Atlante presenta anche approfondimenti su alcuni luoghi che, pur non ricoprendo prettamente una funzione di centri di raccolta, divennero simbolo e simbolici dell’esodo: Fertilia, nei pressi di Alghero; il Quartiere Giuliano Dalmata di Roma; il Villaggio San Marco di Fossoli di Carpi; la Caserma di via Pradamano a Udine, che funzionò come centro di smistamento per migliaia di profughi.
Le schede georeferenziate dei campi ricostruiscono i principali passaggi che hanno scandito l’attività e il funzionamento delle diverse strutture, consentendo di allargare lo spettro: si restituisce così non solo la geografia dell’esodo e il suo impatto nelle diverse aree del Paese, ma anche i meccanismi delle politiche di gestione e assistenza ai profughi adottate dal Governo italiano. Quest’ultimo, muovendosi in un quadro nazionale e internazionale estremamente complesso, si trovò, di fronte a flussi divenuti sempre più consistenti, nella condizione di mettere in moto una vera e propria macchina dell’accoglienza che ebbe nei campi un segmento decisivo.
Un segmento che, oltretutto, ben descrive le dinamiche che portarono gli apparati governativi, dopo una fase iniziale di prima assistenza, a orientarsi, lentamente e non senza difficoltà, verso indirizzi più organici e sistematizzati che, basati prevalentemente sulle direttrici dell’inserimento lavorativo e della sistemazione abitativa poi sfociata nella costruzione dei Villaggi Giuliani, costituirono la risposta a una situazione improvvisa e di vasta portata, inserita nei contorni fragili dell’immediato dopoguerra. Dalla storia dei centri di raccolta emergono anche le politiche migratorie adottate a livello nazionale e internazionale per ricollocare o favorire l’emigrazione in altri paesi dei profughi e dei rifugiati. Queste politiche potrebbero essere ulteriormente indagate ampliando la ricerca ai campi specificamente destinati a tale scopo.
Il campo rappresenta dunque un punto di osservazione imprescindibile per lo studio della diaspora giuliano-dalmata e per la ricostruzione delle politiche assistenziali intraprese dai vertici governativi nei confronti degli esuli: la loro storia, se inquadrata in una prospettiva più ampia, racconta quella della lunga e difficile ricostruzione che precede la stagione della grande trasformazione del nostro Paese.
Metodologia
Attraverso un’accurata indagine condotta su un ampio ventaglio di fonti, in larga parte ma non esclusivamente italiane, si è cercato di arrivare a una quantificazione, il più precisa possibile, delle strutture e dei profughi che, in momenti diversi, transitarono al loro interno.
A essere considerati, come sottolineato in precedenza, sono stati i complessi gestiti, attraverso le prefetture, direttamente dal Ministero dell’Interno, che li ereditò dal dissolto ministero dell’Assistenza post-bellica.
Luoghi inutilizzati, riadattati, rifunzionalizzati e ricondizionati per il nuovo uso: un totale di 109 strutture – numero ampiamente condiviso sul piano storiografico – destinate a ridursi negli anni seguenti (41 nel 1952, 25 nel 1955), prima di chiudere i battenti intorno alla prima metà degli anni Settanta.
Le schede presentate in questa prima fase del progetto riguardano 60 campi e ricostruiscono anche la storia delle strutture analizzate sia prima del loro utilizzo per accogliere i profughi giuliano-dalmati, sia dopo la loro dismissione. Sono state inoltre segnalate le eventuali significazioni dei luoghi in cui sono state collocate targhe o segni di memoria relativi alla presenza dei profughi.
Centri ufficiali – questa la definizione che potrebbe essere applicata – ai quali se ne affiancarono certamente altri, dall’attività più breve e dai contorni più frastagliati, al cui interno l’assistenza era demandata a soggetti diversi, pubblici e privati, ma che – per il loro carattere frammentario – sono rimasti al di fuori del campo di indagine del presente lavoro, pur restando un possibile oggetto di approfondimento in uno studio successivo. Uno studio che dovrebbe evidentemente concentrare l’attenzione anche su una serie di strutture che assunsero rilevanza nell’economia della gestione dell’esodo, come, solo per citare alcuni esempi, i centri di prima accoglienza funzionanti nei porti di Venezia e Ancona o, ancora, i molti centri di ricovero temporaneo sparsi nelle diverse regioni della penisola.
Attraverso una scheda tipo, variabile in base alle informazioni reperite e al periodo di funzionamento, la storia e l’evoluzione di ogni singolo campo è ricostruita non solo attraverso fonti primarie, a cominciare dalla documentazione archivistica, e secondarie, ma anche mediante l’utilizzo di fonti narrative (testimonianze e cronache) ed emerografiche (articoli di quotidiani dell’epoca), unitamente a citazioni letterarie, cinegiornali e fotografie
Una prospettiva in grado di far emergere anche le politiche avviate da agenzie internazionali come la United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), l’International Refugee Organization (IRO) e, in una fase successiva, l’Amministrazione per gli Aiuti Internazionali (AAI) che, preposte al rimpatrio, all’assistenza e al ricollocamento (resettlement) attraverso programmi di emigrazione assistita in altri paesi di rifugiati e Displaced Person’s (DP), tracciarono traiettorie che in più di un’occasione si incrociarono, anche nei campi, con quelle dei profughi giuliano-dalmati. Questi ultimi, come emerge dalle schede, costituirono il nucleo numerico più rappresentativo nei diversi campi, trovandosi però a condividere, spesso con esiti diversi, gli stessi spazi e i medesimi ambienti con altre tipologie di profughi, in primis quelli provenienti dalle ex colonie dell’Africa orientale italiana, dalla Grecia e dal Dodecaneso, cui si aggiunsero, in alcuni casi, ebrei, ex prigionieri, sfollati e sinistrati di guerra in attesa di definitiva collocazione.
Un’umanità varia, vittima della guerra,, le cui vicende richiamano certamente a una cornice più ampia, che il progetto intende indagare nelle sue fasi successive, attraverso la mappatura di altre strutture e di profuganze diverse per tipologia e provenienza geografica. di profuganze diverse per tipologia e provenienza geografica.
Fonti e bibliografia
Tra le fonti primarie, la ricerca ha interrogato principalmente i fondi conservati presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, l’Archivio Centrale dello Stato e l’Archivio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento all’Archivio dell’Ufficio per le Zone di Confine, ancora in buona parte inesplorato per quello che riguarda la distribuzione e l’assistenza ai profughi nei diversi contesti locali. Altrettanto preziosi per individuare i campi e quantificare il numero dei profughi, laddove è stato possibile reperirli, si sono rivelati i fondi delle Prefetture e degli Enti comunali di assistenza (Eca), conservati negli Archivi di Stato e negli Archivi storici comunali delle diverse località che ospitavano i centri di raccolta.
Tra le fonti secondarie, punto di riferimento essenziale è rappresentato dal materiale a stampa (opuscoli, relazioni, consuntivi, ecc.) prodotto dall’associazionismo giuliano-dalmata (si pensi al materiale prodotto dall’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati), da quello cattolico (Pontificia commissione di assistenza) e dalla Croce rossa italiana, solo per citare quelli principali, unitamente ai quotidiani a carattere nazionale e locale. Tra le fonti incrociate nella redazione delle schede è da sottolineare il ruolo assunto da «L’Arena di Pola», testata che, a partire dal giugno 1948, inaugurò un’apposita rubrica sui centri di raccolta, una sorta di veri e propri reportage che, con cadenza periodica, restituivano approfondimenti sui diversi campi, rivelandosi così uno strumento di notevole interesse. Fondato a Pola nel 1945 come organo di informazione in lingua italiana durante il periodo del Governo Militare Alleato, il quotidiano divenne la voce dell’esodo e, dopo il trasferimento della redazione in Italia nel maggio 1947, restò il giornale degli esuli, che continuarono a leggerlo da ogni angolo della penisola.
Quando possibile è stato analizzato anche materiale iconografico, cinematografico e audiovisivo in grado di dialogare con le altre fonti.
Imprescindibile poi la principale letteratura sul tema, che ha inteso considerare, nell’ottica di offrire una fotografia dai contorni nitidi, elementi di storia locale, intrecciati con ricerche sul tema e una produzione storiografica di respiro più ampio.